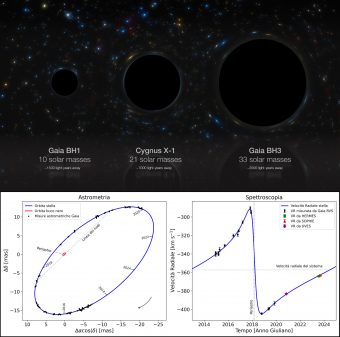In Jackson Heights, docu-film di Frederick Wiseman. Presentato alla Mostra del cinema 2015 fuori concorso.
In Jackson Heights, docu-film di Frederick Wiseman. Presentato alla Mostra del cinema 2015 fuori concorso.
 Tre ore e dieci (distillate da 120 ore di girato) per raccontarci un quartiere di New York-Queens dove convivono 167 minoranze linguistiche. Forse questo film del guru del cinema di osservazione Federick Wiseman voleva essere un inno al multiculturalismo, finisce invece col mostrarci un pulviscolo di identità etniche, religiose, sessuali che vivono vicine, si sfiorano, ma restano incapsulate dentro il proprio microcosmo. Voto 7
Tre ore e dieci (distillate da 120 ore di girato) per raccontarci un quartiere di New York-Queens dove convivono 167 minoranze linguistiche. Forse questo film del guru del cinema di osservazione Federick Wiseman voleva essere un inno al multiculturalismo, finisce invece col mostrarci un pulviscolo di identità etniche, religiose, sessuali che vivono vicine, si sfiorano, ma restano incapsulate dentro il proprio microcosmo. Voto 7
 85 anni, carriera lunga e gloriosissima, premi incamerati dappertutto (compreso un leone alla carriera a Venezia 2014). Frederick Wiseman è un maestro venerato del docufilm, un guru del cinema di osservazione in grado di mettere d’accordo tutte le generazioni cinefile (e i jeunes critiques sui vent’anni e qualcosa son sempre i più entusiasti, i primi a genuflettersi al cospetto dell’opera sua). E però no che non molla mister Wiseman, visto che continua a realizzare film alla media di uno all’anno, un ritmo che schianterebbe pure un robusto giovanotto, anche perché tenete conto che i suoi lavori non son mica dei corti, anzi son dei lunghi, anzi dei lunghissimi tra le tre e le quattro ore di durata. Distillate peraltro da un girato di dimensioni sterminate (per In Jackson Heights 120 ore). Che quando a un festival, e capita spesso, vedi in programma un Wiseman nuovo un filo di ansia ti coglie e la prima domanda è: adesso come faccio a incastrarlo? (quattro ore sono un’infinità, l’equivalente di altri due-tre film). Tant’è che a Venezia un paio di edizioni fa ho saltato il suo At Berkeley, l’anno scorso a Cannes (lo davano con gran pompa alla Quinzaine) ho fatto lo stesso con National Gallery, poi recuperato altrove. Stavolta a Venezia per i 190 minuti di Jackson Heights, tre ore e dieci, un filo al di sotto del suo solito minutaggio XXL, mi ci sono messo d’impegno tuffandomi in uno screening serale non proprio affollatissimo in sala Darsena, e uscendone in un Lido desertificato e sinistro che era quasi la una. Però con l’allegrezza di chi ha fatto il dovere suo. Che se no come fai a sostenere la muta riprovazione dei fan(atici) di Wiseman se dici di aver scansato il suo ennesimo quanto presunto capolavoro? Però, cerchiamo di essere sereni e massimamente laici anche di fronte al mito Wiseman senza lasciarci fuorviare dalla devozione imperante. E allora diciamo che At Jackson Heights è un gran bel documentario, e però esiterei a spendere la parola capolavoro. Vispo e fresco, come no, godibile alla visione, un film che cattura pezzi di vita e il loro farsi e srotolarsi con intatta capacità di osservazione e penetrazione da parte del suo autore, un miracolo per uno che viaggia verso i novant’anni, e però docu non così travolgente, soprattutto gravato – al di là della sua apparente e dichiarata oggettività – da un certo intento dimostrativo. Vale a dire che l’utopia multiculturale è possibile, anzi si è già materializzata in posti come quelli del titolo.
85 anni, carriera lunga e gloriosissima, premi incamerati dappertutto (compreso un leone alla carriera a Venezia 2014). Frederick Wiseman è un maestro venerato del docufilm, un guru del cinema di osservazione in grado di mettere d’accordo tutte le generazioni cinefile (e i jeunes critiques sui vent’anni e qualcosa son sempre i più entusiasti, i primi a genuflettersi al cospetto dell’opera sua). E però no che non molla mister Wiseman, visto che continua a realizzare film alla media di uno all’anno, un ritmo che schianterebbe pure un robusto giovanotto, anche perché tenete conto che i suoi lavori non son mica dei corti, anzi son dei lunghi, anzi dei lunghissimi tra le tre e le quattro ore di durata. Distillate peraltro da un girato di dimensioni sterminate (per In Jackson Heights 120 ore). Che quando a un festival, e capita spesso, vedi in programma un Wiseman nuovo un filo di ansia ti coglie e la prima domanda è: adesso come faccio a incastrarlo? (quattro ore sono un’infinità, l’equivalente di altri due-tre film). Tant’è che a Venezia un paio di edizioni fa ho saltato il suo At Berkeley, l’anno scorso a Cannes (lo davano con gran pompa alla Quinzaine) ho fatto lo stesso con National Gallery, poi recuperato altrove. Stavolta a Venezia per i 190 minuti di Jackson Heights, tre ore e dieci, un filo al di sotto del suo solito minutaggio XXL, mi ci sono messo d’impegno tuffandomi in uno screening serale non proprio affollatissimo in sala Darsena, e uscendone in un Lido desertificato e sinistro che era quasi la una. Però con l’allegrezza di chi ha fatto il dovere suo. Che se no come fai a sostenere la muta riprovazione dei fan(atici) di Wiseman se dici di aver scansato il suo ennesimo quanto presunto capolavoro? Però, cerchiamo di essere sereni e massimamente laici anche di fronte al mito Wiseman senza lasciarci fuorviare dalla devozione imperante. E allora diciamo che At Jackson Heights è un gran bel documentario, e però esiterei a spendere la parola capolavoro. Vispo e fresco, come no, godibile alla visione, un film che cattura pezzi di vita e il loro farsi e srotolarsi con intatta capacità di osservazione e penetrazione da parte del suo autore, un miracolo per uno che viaggia verso i novant’anni, e però docu non così travolgente, soprattutto gravato – al di là della sua apparente e dichiarata oggettività – da un certo intento dimostrativo. Vale a dire che l’utopia multiculturale è possibile, anzi si è già materializzata in posti come quelli del titolo.
Wiseman si mostra fedele a se stesso e al suo fare cinema al massimo grado, non deflettendo mai dalle regole, dai codici, che si è stabilito. Macchina da presa messa e mossa a registrare l’oggettivo, il così-com’è, senza bellurie, senza affettazioni e ricerche stilistiche che possano contaminare la rappresentazione del vero. Niente mezzibusti parlanti, i tanto aborriti talking heads, a spiegare e guidare lo spettatore guardando magari dritti in macchina. Niente didascalie, niente scritte, niente segnaletica, solo un flusso di immagini, e zero voice over. Il metodo Wiseman, pezzi e frammenti e sequenze connessi da un editing che è il vero mezzo con cui si costruisce la narrazione e si dà senso alla materia filmata, un metodo che ha stravinto in campo documentario (ormai appare cosa assai cheap e retroguardista mostrare interviste in un docu, fare commenti dentro e fuori campo, ed è tutto un accostare e disgiungere e riaccostare in fase di montaggio. A la Wiseman, per l’appunto). Stavolta il Venerato Maestro – che però non se la tira per niente e non è schiavo della sua leggenda – ci porta a Jackson Heights nei Queens, uno dei boroughs della municipalità di New York e, semplicemente e mirabilmente, ce lo mostra attraverso chi ci abita (le sequenze per così dire non abitate, di puro ambiente e contesto, son pochissime). Quartiere multikulti come nessun altro negli Stati Uniti, le note che accompagnano il film ci dicono che in JH convivono la bellezza di 167 nuclei linguisticamente diversi. Sicché il film si presenta come il cantico del multiculturalismo, come l’inno alla convivenza delle diversità e fors’anche all’inesausta efficienza del crogiolo americano nel miscelare, se non proprio amalgare, le differenze e renderle compatibili con la matrice culturale nazionale originaria. Quartiere popolare, Jackson Heights, dove fino a ieri le case avevano prezzi accessibili e dunque calamita per recenti immigrati da mezzo mondo e ceti medio-bassi cui erano impediti gli affitti di Manhattan, ma anche della Brooklyn ormai hipsterizzata. Gente da ogni dove, negozi e negozietti etnici con insegne in ogni lingua, e un gran miscuglione di cibi e sapori e odori. Da deliziare il pubblico e la stampa di massima correttezza democratica dei festival, e difatti a Venezia il gradimento è stato alto (e già qualcuno pensa a un film analogo su Via Padova a Milano, e in effetti non sarebbe una cattiva idea). Col suo formidabile occhio Wiseman coglie benissimo il carattere di crocevia di Jackson Heights, presentandoci uno dopo l’altro facce e voci e corpi che davvero, e senza retorica ma con la pura forza del proprio esserci, ci raccontano il mondo, semplicemente. Le etnie saranno anche 167, ma a essere egemoni – così almeno emerge dal film – sono i latinoamericani, colombiani, honduregni, messicani, venezuelani, peruviani, e via proseguendo coll’atlante centro- e sud-americano. In Jackson Heights è la prova evidente di come siano gli ispanici la minoranza-maggioranza in grado di incidere sullo stesso presente e futuro dell’America tutta, quella con cui si dovranno fare i conti. Le altre culture – l’asiatica, l’araba e più in generale islamica – non sembrano avere la stessa densità fisica, la stessa strabordante presenza, almeno per ora. Vediamo una preghiera in moschea e una madrassa con un maestro che insegna a sillabare in arabo, la lingua del Corano, ai suoi allievi bambini. Ma è nutrita nel quartiere anche la rappresentanza ebraica (e però la sinagoga, ricorda qualcuno, è sempre meno frequentata per via della laicizzazione arrembante e ormai è diventata il luogo di incontro per altri gruppi, altre minoranze, compresi se ricordo bene gli omosessuali anziani, pardon seniors). Può in un posto così mancare una battagliera rappresentanza LGBT? Certo che no, e allora via con le immagini della gay parade cui partecipa anche il sindaco di NY Di Blasio, via con le riunioni di autocoscienza e autoaiuto degli anziani gay di cui sopra, via con i transgender che si lamentano delle malversazioni polizieschi (e dei negozianti e baristi che non li vogliono). Riunioni, meetings, manifestazioni, assemblee, gruppi di discussione. Ecco, mai, o quasi mai, che Wiseman ci mostri delle individualità, nel suo film il singolo è annegato dentro l’insieme cultural-linguistico-etnico-religioso di appartenza. Si procede nella narrazione per entità sovraindividuali, i Colombiani, i Messicani, gli Indiani, gli Ebrei, i Gay, i Transgender, e avanti così nelle infinite declinazioni della scala identitaria. Cosa da lasciare abbastanza perplessi. L’approccio di Wiseman è quello sociologistico e un filo vetero-militante e leftist per cui il corpo sociale è più un assemblaggio di molecole, di comunità piccole medie o grandi, che di atomi. In Jackson Heights quasi mai cattura e racconta storie singole (tra le eccezioni, quella della signora quasi centenaria di una casa di riposo ebraica), e anche le storie personali si fanno emblematiche e sintomo di una più larga e allarmante realtà sociale (è il caso della signora messicana che racconta l’odissea della figlia immigrata clandestina). Ma Wiseman ha un tale occhio e una tale abilità nell’intercettare il reale da comporre un film che, paradossalmente, finisce col dirci molto di più e di diverso dei suoi stessi presupposti e enunciati, e delle sue stesse intenzioni. Se con In Jackson Heights si voleva mostrare e dimostrare come la confluenza delle diversità sia possibile, anzi sia già avvenuta in questo quartiere microcosmo che prefigura il mondo futuro, il risultato rischia di essere l’opposto. Sfilano davanti a noi infiniti frammenti delle più svariate culture, corpuscoli di ogni tipo e colore, ma ognuno incapsulato nel proprio universo, segnato dal proprio marchio identitario, con barriere invisibili quanto ferrigne tra l’uno e l’altro. Universi minimi che vivono accanto, si sfiorano, interagiscono in superficie ma restano nel profondo separati e non-comunicanti. Allineare sulla stessa strada ristoranti cinesi, coreani, indiani, messicani, giapponesi, guatemaltechi non significa, in tutta evidenza, aver creato una nuova, superiore identità in grado di bruciare e sublimare le sottoidentità preesistenti, vuol dire tutt’al più aumentare l’offerta merceologica. I colombiani che nel loro bar di riferimento si guardano su schermi giganteschi le partite della loro nazionale e tifano contro tutti e contro il mondo ci dicono che ognuno rimane sul suo terreno di gioco, pronto a difenderlo da ogni invasione di campo. Altro che multikulti. Del resto, Jackson Heights sta già cambiando pelle e anche radici, ed è probabile che le sue 167 isole linguistiche verranno scagliate nel grande mare americano ben presto. L’assemblea, che Wiseman ben ci racconta, dei piccoli negozianti in procinto di essere sloggiati per far posto a un nuovo centro commerciale di brand coolissimi e hipsterizzanti ci fa capire come sia imminente quanto successo nell’ultima decade a Brooklyn. La gentrificazione. Via i ceti popolari, via le molte etnie, largo ai signori e signorini dei mestieri fighetti-creativi ben pagati che potranno permettersi i prezzi, di molto aumentati, delle case. Alla faccia della multietnicità.
Venezia 72. Recensione: IN JACKSON HEIGHTS di Frederick Wiseman
↧
↧
Trending Articles
More Pages to Explore .....